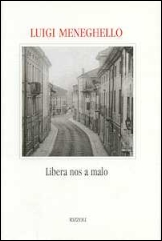 «C’è molto rame in casa, secchi, testi, stampi, leccarde, paioli». Questa frase apparentemente innocua si trova a metà del tredicesimo capitolo di Libera nos a malo, il capolavoro di Luigi Meneghello. A prima vista non è che una dimessa elencazione di vetusti arnesi da cucina affratellati da una comune natura cuprica, eppure mi è rimasta in mente per ore. Anche adesso che ho doppiato la pagina che la ospita, essa si ripresenta a intervalli regolari e si sovrappone alle parole che vado leggendo, dolce come una litania melodiosa e arcana, ossessiva come il ritornello di una canzonetta: secchi, testi, stampi, leccarde, paioli. Che sarà mai? Donde verrà questa malìa che a queste parole m’incatena? Devo disvelare il segreto di codesto incantamento, spezzarlo per poter completare libero da sortilegi la degustazione delle pagine rimanenti.
«C’è molto rame in casa, secchi, testi, stampi, leccarde, paioli». Questa frase apparentemente innocua si trova a metà del tredicesimo capitolo di Libera nos a malo, il capolavoro di Luigi Meneghello. A prima vista non è che una dimessa elencazione di vetusti arnesi da cucina affratellati da una comune natura cuprica, eppure mi è rimasta in mente per ore. Anche adesso che ho doppiato la pagina che la ospita, essa si ripresenta a intervalli regolari e si sovrappone alle parole che vado leggendo, dolce come una litania melodiosa e arcana, ossessiva come il ritornello di una canzonetta: secchi, testi, stampi, leccarde, paioli. Che sarà mai? Donde verrà questa malìa che a queste parole m’incatena? Devo disvelare il segreto di codesto incantamento, spezzarlo per poter completare libero da sortilegi la degustazione delle pagine rimanenti.
Il libro, innanzitutto, overossia il contesto in cui quella frase opera. Libera nos a malo è un racconto dominato da un acuto senso di displacement, di extraterritorialità, di migranza, di alloglossia perfino. È un memoir scritto in italiano da un italiano imbevuto di lingua inglese che dentro di sé, negli strati più profondi e radicali dell’essere suo, parla il dialetto di Malo, provincia di Vicenza. La lingua e il paese nativo, non l’io narrante, sono i protagonisti indiscussi di un sofferto rimpatrio, un tentativo disperatissimo e matto di ricostruire pezzo per pezzo le cose dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il recupero delle parole usate per renderle presenti. Il dialetto di Malo è dunque il linguaggio naturale della vita vissuta, dell’esperienza, mentre l’italiano è quello artificiale della cultura, delle idee ricevute, dello studio.
 Il castello dei fantasmi incrociati
Il castello dei fantasmi incrociati Bottega di lettura
Bottega di lettura i monologhi della varechina
i monologhi della varechina sacripante!
sacripante!