 1884. Edmondo De Amicis sale a bordo del piroscafo Nord America, destinazione Montevideo. Cinque anni più tardi il racconto di quel viaggio sarebbe stato pubblicato con il titolo Sull’oceano, un libro strano e lievemente teratologico: un po’ resoconto giornalistico, un po’ esercizio di ritrattistica letteraria, un po’ saggio sui vizi, le virtù e i destini della specie umana. Un mostriciattolo, ma non sgradevole, ingentilito da una scrittura limpida e pacata, colloquiale, confidenziale. Il piroscafo aveva biglietti di prima, seconda e terza classe, e in quest’ultima viaggiavano le avanguardie di quell’imponente flusso migratorio che a partire dalla fine dell’800 avrebbe portato milioni di diseredati italiani a cercare fortuna all’estero.
1884. Edmondo De Amicis sale a bordo del piroscafo Nord America, destinazione Montevideo. Cinque anni più tardi il racconto di quel viaggio sarebbe stato pubblicato con il titolo Sull’oceano, un libro strano e lievemente teratologico: un po’ resoconto giornalistico, un po’ esercizio di ritrattistica letteraria, un po’ saggio sui vizi, le virtù e i destini della specie umana. Un mostriciattolo, ma non sgradevole, ingentilito da una scrittura limpida e pacata, colloquiale, confidenziale. Il piroscafo aveva biglietti di prima, seconda e terza classe, e in quest’ultima viaggiavano le avanguardie di quell’imponente flusso migratorio che a partire dalla fine dell’800 avrebbe portato milioni di diseredati italiani a cercare fortuna all’estero.
Dato l’argomento, non è raro che la lettura inneschi rimandi alle migrazioni contemporanee, fenomeno in cui il ruolo dell’Italia risulta invertito, da porto di partenza ad agognata meta di masse disperate. Trascrivo un brano che — mutando l’America in Italia e l’Italia in Africa — potrebbe essere letto con profitto da chi oggi nega l’umanissima miseria che “ci urla e ci singhiozza alla porta” e la usa come merce di scambio politico, non molto diverso, in questo, dai delinquenti che “fiutano la disperazione nelle capanne e la comprano”.
Certo, in quel gran numero, ci saranno stati molti che avrebbero potuto campare onestamente in patria, e che non emigravano se non per uscire da una mediocrità, di cui avevano torto di non accontentarsi; ed anche molti altri che, lasciati a casa dei debiti dolosi e la reputazione perduta, non andavano in America per lavorare, ma per vedere se vi fosse miglior aria che in Italia per l’ozio e la furfanteria. Ma la maggior parte, bisognava riconoscerlo, eran gente costretta a emigrare dalla fame, dopo essersi dibattuta inutilmente, per anni, sotto l’artiglio della miseria.
(…) La pietà era loro dovuta intera e profonda. E mettevano più pietà, se si pensava a quanti di loro avevan già forse in tasca dei contratti rovinosi, stretti con gli incettatori che fiutano la disperazione nelle capanne e la comprano; a quanti sarebbero stati afferrati all’arrivo da altri truffatori e sfruttati tirannicamente per anni; a quanti altri forse portavano già nel corpo, da troppo tempo malnutrito e fiaccato dalle fatiche, il germe d’una malattia che li avrebbe uccisi nel nuovo mondo.
E avevo un bel pensare alle cagioni remote e complesse di quella miseria, davanti alla quale, come disse un ministro, “ci troviamo altrettanto addolorati che impotenti”, all’impoverimento progressivo del suolo, all’agricoltura trasandata per la rivoluzione, alle imposte aggravate per necessità politica, alle eredità del passato, alla concorrenza straniera, alla malaria. (…) Non mi potevo levar dal cuore che ci avevano pure una gran parte di colpa, in quella miseria, la malvagità e l’egoismo umano: tanti signori indolenti per cui la campagna non è che uno spasso spensierato di pochi giorni e la vita grama dei lavoratori una querimonia convenzionale d’umanitari utopisti, tanti fittavoli senza discrezione né coscienza, tanti usurai senza cuore né legge, tanta caterva d’impresari e di trafficanti, che voglion far quattrini a ogni patto.
(…) E poi mi venivano in mente i mille altri, che, empitisi di cotone gli orecchi, si fregan le mani, e canticchiano; e pensavo che c’è qualche cosa di peggio che sfruttar la miseria e sprezzarla: ed è il negare che esista, mentre ci urla e ci singhiozza alla porta.
[Edmondo De Amicis, Sull’Oceano, Ibis 1991, pag. 51-54]
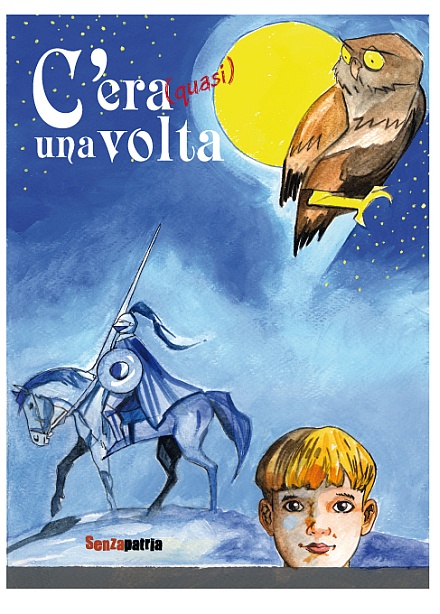
 Il 22 dicembre 2009
Il 22 dicembre 2009 
 La casa editrice
La casa editrice  Che Tolstoj appartenga al ramo stellare della letteratura mondiale di tutti i tempi non è una novità, ma fra poco, per celebrare il centenario della morte,
Che Tolstoj appartenga al ramo stellare della letteratura mondiale di tutti i tempi non è una novità, ma fra poco, per celebrare il centenario della morte, 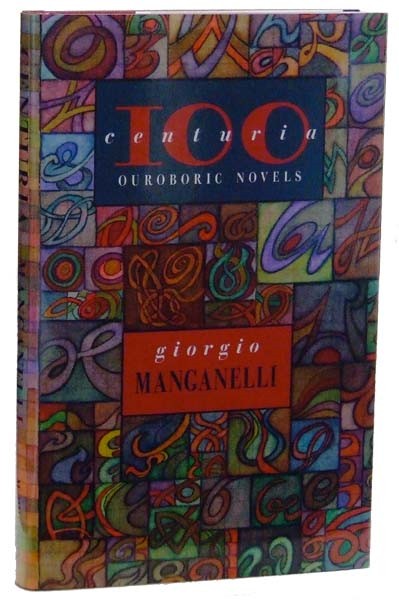


 Capisco l’ineluttabile necessità di pubblicare l’instant book elettorale del padrone; capisco che non si sputa nel piatto in cui si mangia; capisco che per amor di bilancio si ceda alla tentazione di pubblicare robaccia.
Capisco l’ineluttabile necessità di pubblicare l’instant book elettorale del padrone; capisco che non si sputa nel piatto in cui si mangia; capisco che per amor di bilancio si ceda alla tentazione di pubblicare robaccia. 1884. Edmondo De Amicis sale a bordo del piroscafo Nord America, destinazione Montevideo. Cinque anni più tardi il racconto di quel viaggio sarebbe stato pubblicato con il titolo Sull’oceano, un libro strano e lievemente teratologico: un po’ resoconto giornalistico, un po’ esercizio di ritrattistica letteraria, un po’ saggio sui vizi, le virtù e i destini della specie umana. Un mostriciattolo, ma non sgradevole, ingentilito da una scrittura limpida e pacata, colloquiale, confidenziale. Il piroscafo aveva biglietti di prima, seconda e terza classe, e in quest’ultima viaggiavano le avanguardie di quell’imponente flusso migratorio che a partire dalla fine dell’800 avrebbe portato milioni di diseredati italiani a cercare fortuna all’estero.
1884. Edmondo De Amicis sale a bordo del piroscafo Nord America, destinazione Montevideo. Cinque anni più tardi il racconto di quel viaggio sarebbe stato pubblicato con il titolo Sull’oceano, un libro strano e lievemente teratologico: un po’ resoconto giornalistico, un po’ esercizio di ritrattistica letteraria, un po’ saggio sui vizi, le virtù e i destini della specie umana. Un mostriciattolo, ma non sgradevole, ingentilito da una scrittura limpida e pacata, colloquiale, confidenziale. Il piroscafo aveva biglietti di prima, seconda e terza classe, e in quest’ultima viaggiavano le avanguardie di quell’imponente flusso migratorio che a partire dalla fine dell’800 avrebbe portato milioni di diseredati italiani a cercare fortuna all’estero. [ringrazio
[ringrazio  Circa tre anni fa l’editore
Circa tre anni fa l’editore  Il castello dei fantasmi incrociati
Il castello dei fantasmi incrociati Bottega di lettura
Bottega di lettura i monologhi della varechina
i monologhi della varechina sacripante!
sacripante!