
Io, quando ho letto la famigerata lettera di Pier Luigi Celli al figlio, me n’è venuta in mente un’altra, una lettera che Niccolò Machiavelli scrisse al figlio Guido il 2 aprile 1527. L’ultima, perché il Segretario fiorentino sarebbe morto il 22 giugno successivo. Trascrivo i primi due paragrafi, sufficienti a marcare la differenza fra il burocrate di cinquecento anni fa e quello odierno.
Guido figliuolo mio carissimo. Io ho avuto una tua lettera, la quale mi è stata gratissima, maxime perché tu mi scrivi che sei guarito bene, che non potrei havere havuto maggiore nuova; che se Iddio ti presta vita, et a me, io credo farti huomo da bene, quando tu vuogli fare parte del debito tuo; perché, oltre alle grandi amicitie che io ho, io ho fatto nuova amicitia con il cardinale Cibo et tanta grande, che io stesso me ne maraviglio, la quale ti tornerà a proposito; ma bisogna che tu impari, et poiché tu non hai più scusa del male, dura fatica in imparare le lettere et la musica, ché vedi quanto honore fa a me un poco di virtù che io ho; sì che, figliuolo mio, se tu vuoi dare contento a me, et fare bene et honore a te, studia, fa bene, impara, ché se tu ti aiuterai, ciascuno ti aiuterà.
El mulettino, poiché gli è impazato, si vuole trattarlo al contrario degli altri pazzi: perché gli altri pazzi si legano, et io voglio che tu lo sciolga. Daràlo ad Vangelo, et dirai che lo meni in Montepugliano, et dipoi gli cavi la briglia et il capestro, et lascilo andare dove vuole ad guadagnarsi il vivere et ad cavarsi la pazzia. Il paese è largo, la bestia è piccola, non può fare male veruno; et così sanza haverne briga, si vedrà quello che vuol fare, et sarai a tempo ogni volta che rinsavisca a ripigliallo.
Nel primo paragrafo Machiavelli dice senza ipocrisia che, quando verrà il momento, sfrutterà la sua rete di relazioni per aiutare il figlio a fare carriera, cosa che Celli non ammetterebbe nemmeno sotto tortura. E però aggiunge: studia, fa bene, impara. In altre parole, laddove il Celli scioccamente ravvisa una palingenesi nell’espatrio, il Machiavelli avvisa il figlio che in mancanza di studio e applicazione resterà una capra ovunque egli vada.
Il secondo paragrafo è un capolavoro. Ma davvero, neh, mica per scherzo. È la prosecuzione per metafora di quello studia, fa bene, impara.
I figli, proprio come i puledri, a una certa età impazziscono: vogliono prendere strade inconsuete, fare di testa loro, sfidare il mondo. Ci sono padri come Celli che impongono ai figli impazati la briglia e il capestro dei propri pregiudizi: fai questo, fai quello, vai all’estero, da’ retta a me che sono uomo di mondo. Ci sono padri come Machiavelli che li lasciano andare dove vogliono a guadagnarsi il vivere, sperando che rinsaviscano.
Come figlio ho già dato, non posso tornare indietro. Come padre spero in un destino simile a quello di Niccolò Machiavelli: sparire da questo mondo molto prima di cedere alla tentazione di imporre briglia e capestro ai miei figli, quando impazziranno.


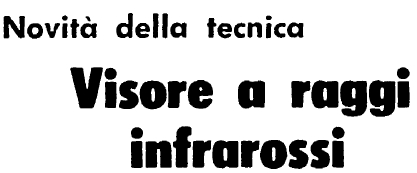

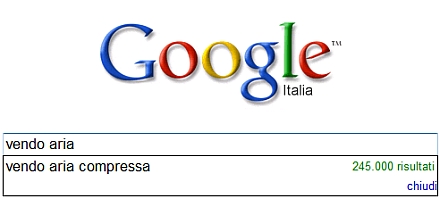 L’altro giorno, assieme a un mio socio, ero al telefono con Jack, un americano che adesso abita in Australia, che ci aveva chiamato per raccontarci quanto gli sarebbe piaciuto che la nostra azienda distribuisse in Italia certi prodotti americani che la sua azienda già distribuisce in Australia, Gran Bretagna e Olanda.
L’altro giorno, assieme a un mio socio, ero al telefono con Jack, un americano che adesso abita in Australia, che ci aveva chiamato per raccontarci quanto gli sarebbe piaciuto che la nostra azienda distribuisse in Italia certi prodotti americani che la sua azienda già distribuisce in Australia, Gran Bretagna e Olanda.
 Uno
Uno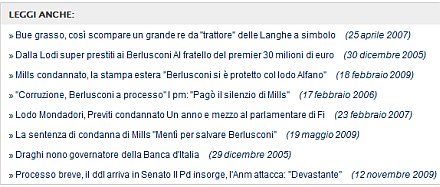
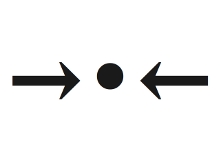 La diatriba è l’anima della cultura. Platonici vs. Aristotelici, Nutella vs. CiaoCrem, Tolstoj vs. Dostoevskij, Coca vs. Pepsi, Antichi vs. Moderni, Indiani vs. Cowboy, e via così. Date in pasto all’umanità una materia opinabile, e subito sorgeranno due eserciti contrapposti e armati fino ai denti.
La diatriba è l’anima della cultura. Platonici vs. Aristotelici, Nutella vs. CiaoCrem, Tolstoj vs. Dostoevskij, Coca vs. Pepsi, Antichi vs. Moderni, Indiani vs. Cowboy, e via così. Date in pasto all’umanità una materia opinabile, e subito sorgeranno due eserciti contrapposti e armati fino ai denti. Il castello dei fantasmi incrociati
Il castello dei fantasmi incrociati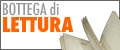 Bottega di lettura
Bottega di lettura i monologhi della varechina
i monologhi della varechina sacripante!
sacripante!